Pier Vincenzo Mengaldo
scriveva che un’Antologia, com’è del resto questo annuario, è un peculiare
genere metaletterario. In effetti radunare in un unico testo tanti scritti
di diversi poeti e critici letterari è un atto che va “oltre” il
semplice intento letterario. È una specie di dichiarazione di poetica che
costringe il curatore ad uno sforzo di ricerca e di analisi nella valutazione
di quanto accade nel mondo della scrittura.
D’altra parte, solo a
scorrere le pagine di questo prezioso Annuario, ci si accorge di nomi che
rientrano tra i principali protagonisti della produzione letteraria italiana.
Certo, magari per qualcuno, ci sono nomi mancanti. Ma un’Antologia non pretende
di essere la consacrazione né tanto meno una lezione di verità. Si tratta
semplicemente di un riconoscimento, di una presa d’atto che per lo meno la
scrittura è ancora viva e tale pretende di rimanere. Del resto, come viene
esplicitato, nella presentazione, I limoni sono un “prezioso strumento di
aggiornamento e informazione per chi ama la poesia”.
Tutto ciò è ribadito
anche dal saggio “Come (non) fare un’antologia della poesia” di
Francesco De Nicola, che prendendo lo spunto da una recente pubblicazione “Poeti
italiani nati negli anni 60. Letteratura come condizione” (Internopoesia,
2024) a cura di Francesco Napoli, afferma che “di tutti i libri che si
possono pubblicare questo (cioè l’Antologia) ha l’autore più discutibile”
perché spesso “riflette i gusti e le valutazioni” secondo “gli
orientamenti critici del tempo”. E a sostegno della sua tesi riporta vari
esempi, dalle antologie scolastiche a quelle per adepti, che qui è superfluo riferire.
Citerò solo un assunto che condivido in toto: “il compito di un’antologia è
quello di portare alla luce chi luce non ha”, sottolineando, come scrive l’autore,
che spesso le antologie, soprattutto quelle scolastiche, hanno limiti che
pregiudicano la comprensione della poesia, se non del poeta stesso.
L’annuario “I limoni” possiede
a mio avviso una qualità: quella di non presentarsi come il tutto, ma
come parte di un mondo letterario in evoluzione. E lo dimostra andando
direttamente a scegliere le recensioni del presente, in particolare del 2024, di
modo che si dà la possibilità al poeta di presentarsi in una veste critica
riguardante testi di recente pubblicazione, tralasciando invece di riportare,
come le antologie sic et simpliciter, vita e scritti di vari autori autorevoli
e non. Sarà poi il tempo a dar credito o meno ai poeti recensiti.
Va detto che, accanto
alle recensioni, il lettore trova pregevoli saggi che gli permettono una più
matura e completa comprensione della letteratura non solo contemporanea. Mi
limiterò, tuttavia, purtroppo alla sola citazione, sia dei saggi che delle
recensioni, non avendo a disposizione uno spazio necessario per parlare di tutto
e di tutti.
Ecco allora gli autori,
recensori e recensiti, e il contenuto dei vari contributi pubblicati.
I recensori sono: Fabio
Contu, Francesco De Nicola, Alessandro Fo, Alessandro Franci, Giuseppe
Grattacaso, Vincenzo Guarracino, Giuseppe Langella, Massimiliano Mandorlo,
Simona Mancini, Baldo Meo, Francesco Napoli, Lorenzo Pataro, Sara Vergari,
Marco Vitale.
I recensiti sono: Laura
Acerboni, Lorenzo Babini, Pier Luigi Bacchini, Elisa Biagini, Piero Buscioni,
Barbara Carle, Alessandra Corbetta, Maurizio Cucchi, Roberta Dapunt, Mauro De
Maria, Mary de Rachewltz, Massimiliano Luca Delfino, Cinzia Demi, Carlo di
Francescantonio, Alberto De Raco, Paolo Di Stefano, Umberto Fiori, Alessandro
Fo, Erika Formazaric, Alessandro Franci, Giovanna Frene, Andrea Giampietro,
Michele Graziosetto, Maurizio Gregorini, Paolo Lanaro, Giuseppe Lagella,
Manfredi Lanza, Isabella Leardini, Dante Maffia, Roberto Maggiani, Beppe
Mariano, Maurizio Marotta, Vincenzo Mascolo, Francesco Paolo Memmo, Daniele
Mencarelli, Claudia Mencaroni, Marco Pelliccioli, Daniela Pericone, Antonio
Prete, Davide Puccini, Valentino Ronchi, Mauro Sambi, Alberto Schettini, Ida
Travi, Rosella Valdré, Marco Vitale.
Non posso certo
tralasciare di riportare anche gli autori e i titoli dei saggi che ritengo
assai interessanti proprio per quelle peculiarità segnalate in antecedenza.
I saggi sono: “Debut du
siècle in Italia: Aldo Palazzeschi tra liberty, crepuscolarismo e Novecento” di
Francesco Napoli; “Palazzeschi e il futurismo: un rapporto unico” di Federico
Gobbetti; “Le ‘Cannonate’ di Tizzoni-Finzi di fronte al futurismo” di
Elvio Guagnini; “Guardare un’arancia sette volte” di Silvia Vecchini; “Come
(non) fare un’antologia della poesia” di Francesc De Nicola; “Note sulla
punteggiatura nera e bianca nei testi poetici contemporanei” di Elisa Tonani; “L’Orazio
italiano: Giosuè Carducci e l’innovazione metrica del Novecento” di Fabio
Contu; “La trasformazione del testo” di Pier Luigi Ferro; “Il viaggio che
dura di Tommaso Lisi” di Raffaele Pellecchia; “In ricordo di Lorenzo Pataro”
di Giuseppe Grattacaso.
L’annuario termina con l’indicazione
di alcune pubblicazioni di saggistica, di alcune traduzioni, e di alcuni
concorsi.
Ripeto, per finire, l’opportunità
e direi quasi la necessità di libri come “I limoni” perché non se ne sa
mai abbastanza di quello che avviene nel mondo tanto variegato della letteratura
molto spesso legato a correnti, circoli, editori che raccontano solo di se stessi
e non di altri. Io stesso devo confessare che tra gli autori pubblicati posso
dire di conoscerne pochissimi. Ma sento e credo che allargare i propri
orizzonti sia necessario. Alla fine ognuno farà le sue scelte, ma almeno con
conoscenza di causa e senza pregiudizi di sorta.
Enea Biumi










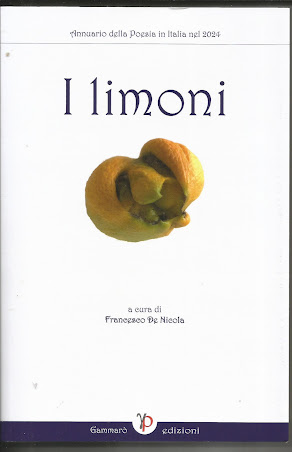

.jpg)












.jpg)